Federico, cecidit sol mundi
L’ultimo viaggio in Apulia, terra dei suoi ritorni
Oltrepassata la linea di confine che la separava dal Sannio, entrò Federico in Puglia, la terra dei suoi ritorni autunnali, in Capitanata, dove sostava con maggiore diletto per i suoi boscosi rilievi collinari, la sua lussureggiante vegetazione, la sua vicinanza al mare, il suo clima temperato, attratto dalle zone umide dell’antica Salapia, in quel verdeggiante territorio ampio e libero, rigoglioso di boschi e ricco di selvaggina dove esercitava la caccia col falcone.
Si portò, Federico, nel castello di Apricena per la sua prima battuta di caccia. Era, quella di Apricena, la prima delle sue domus solatiorum, dimore estive per i godimenti autunnali del sovrano. Ancora oggi, sotto la volta a croce di quel che resta dell’antico maniero, si legge la frase corrosa dal tempo che Federico fece incidere in una delle sue ultime autunnali escursioni, e di cui resta ancora oggi memoria, la scritta duriora deduxi, cioè ne ho piegati di più duri. Sfiorò, il sovrano, Castel Fiorentino, ma non era fra i suoi castelli preferiti e proseguì oltre, diretto a Lucera, rimandando l’appuntamento col destino.
A Lucera era atteso. Preceduto dal suo cerimoniere, aveva tutto predisposto per un ameno sollazzevole soggiorno. L’indomani, di buon’ora, era infatti in agenda la caccia col falcone nella fitta boscaglia circostante. L’aria era pungente e Federico, reduce da un fastidioso raffreddore, si fece portare dal servitorello Marzuch il mantello color porpora foderato di pelliccia, dono di Leopoldo d’Austria nel loro ultimo incontro. Era inquieto il sovrano, e impaziente di cimentare Grifo, il suo falco preferito proveniente dall’addestramento di Salpi. Fatto sellare Dragone, il baio purosangue che il gran maestro Giordano Ruffo aveva scelto per lui nella scuderia imperiale, il sovrano attraversò al galoppo l’imponente portone, il gruppo dei cortigiani al seguito. Dopo aver costeggiato il costone boscoso della fortezza e attraversato il torrente Sàlsola, i cavalieri si inoltrarono veloci lungo la dorsale dei colli della Daunia…
La sera, a cena, indossato il suo zendado blù con risvolti dorati che ancora di più accentuavano il contrasto con la sua rossa capigliatura, il sovrano fece il suo ingresso nel grande salone di rappresentanza, accolto dal deferente saluto degli ospiti. Talvolta si faceva notte, nella gran sala, al lungo tavolo delle riunioni con i ministri che cascavano dal sonno, ma quella sera il sovrano li aveva invitati a cena per un intrattenimento ristoratore nella sala illuminata dalla luce di cento candelabri, mentre leggiadre fanciulle danzavano con movimenti lenti e flessuosi al suono delle ghironde. Per la circostanza Federico aveva ordinato al cuoco una cena sontuosa a base di fresco pescato proveniente dal lago di Varano, innaffiato dal Fiano Bordolese di Napoli.
A Barletta, nella domus che s’era fatto costruire accanto alla torre normanna (ma quanto più elegante e armonica, rispetto alle altre facies castellari) si intrattenne una settimana per ricevere dignitari di corte e ambasciatori, prelati e capitani, filosofi e scienziati ma soprattutto letterati e poeti, per intrattenere gli ospiti della “Scuola Siciliana”, cosiddetta, ma nata e germogliata alle corti di Foggia e Barletta, per assimilare le regole del nuovo idioma apulo toscano che avrebbe ispirato la scrittura della Divina Commedia di Dante (per stessa ammissione del grande poeta).
Barletta. Diversa dalle altre sedi imperiali. Diversa e di più. Non sede occasionale di vicende personali o di amministrazione di routine, ma scelta da Federico per elaborare grandi progetti strategici che avrebbero segnato il destino del Regno: l’organizzazione della sesta Crociata, la Fiera dell’Assunta, gli illuminati incontri con poeti e letterati fra i più rinomati del suo tempo, e poi la riorganizzazione del Regno, l’aggiornamento del Liber Augustalis. Vanto di Barletta, pur se reperto fortuito, il busto dell’imperatore unico al mondo. E l’aquila leporina che egli fece scalpellare nel sesto acuto di una bifora del castello nell’atto di artigliare la preda.
S’inoltrò, Federico, lungo la strada che l’avrebbe portato nel turrito castello di Gioia del Colle dove teneva reclusa Bianca Lancia, la pulcherrima, la “troppo bella” fanciulla verso la quale aveva provato una vera passione tanto da dedicarle la poesia “Poi che di piace amor” la sua lirica più nota. Tre figli erano nati da quell’amore appassionato, Costanza e Violante ma soprattutto Manfredi, il figliuolo prediletto. L’unione con la bella astigiana non poteva però durare per la ragion di Stato, quando il sovrano aveva sposato Isabella d’Inghilterra. E allora – era pur sempre innamoratissimo di lei – vuole la leggenda che l’abbia reclusa nel castello di Gioia. Ma qui voci maligne avrebbero spettegolato al sovrano ch’essa s’era distratta con un paggio e Federico, roso dalla gelosia, le avrebbe fatto tagliare i seni… N’è restata traccia nella mattonella bugnata d’una cortina del castello.
Da Gioia del Colle Federico risalì verso Castel del Monte, il più enigmatico dei suoi castelli, del quale spesso i disinformati si chiedono le ragioni di tanta affezione per quel grandioso maniero e del suo borgo circostante. Al di là degli esagerati esoterismi che inducono a improbabili motivazioni, le vere ragioni vanno ricercate in quei luoghi coperti di alta e fitta boscaglia che declinava in verdi poggi, irrorati da freschi ruscelli, fra la fitta vegetazione in cui si nascondevano alla vista caprioli, lepri e martore. E dalle foreste dell’Appennino scendevano in estate ispidi cinghiali e fra pruneti e cespugli la campagna circostante era animata da conigli e scoiattoli. Senza dire della grande varietà di volatili, sia di quelli stanziali che nidificavano in loco che di quelli che ad ogni stagione migravano in quel territorio nei quale l’imperatore s’attardava a scrivere dell’arte delle loro cacciagione.
S’affrettò, Federico, rapidamente verso la domus di Foggia dove l’attendeva un’ambasceria orientale guidata dall’emiro Fahr ad-Din, plenipotenziario del sultano d’Egitto al-Kamil, col quale si era già intrattenuto a Gerusalemme ai tempi della sesta Crociata a discettare – in lingua araba – di filosofia orientale. Una cena sobria a base di fagiani dell’entroterra dauno e arrosto di capretto innaffiato da un robusto nero di Troia, aveva chiuso una serata assai tribolata, guastata dalla lettura dei dispacci che pressocchè quotidianamente riceveva dalla sua rete di informatori, irritato in particolar modo da un ennesimo messaggio pervenuto dalla Curia pontificia che provocò, nel sovrano, un attacco di bile, che certo non gli allievò la dolorosa gastrite ulcerosa che da giorni lo tormentava.
L’indomani s’inoltrò, il sovrano, diretto al Patrimonium Petri, con l’intenzione di fargliela pagare a papa Innocenzo, il quale – al corrente dei suoi propositi – s’era dato ad una fuga precipitosa attraverso la campagna laziale, raggiungendo il porto di Civitavecchia, pronto a salpare per Genova sua città natale. Ma avvertendo i lancinanti sintomi di una indisposizione intestinale, il sovrano ordinò al seguito e alla scorta di fermarsi al primo ostello lungo la strada per Torremaggiore.
Si avviò quindi Federico incontro al suo destino. E sì che Michele Scoto qualche anno prima gli aveva profetizzato che sarebbe morto “sub flore”, presso una porta di ferro. In un primo momento Federico non ci fece caso, ma essendo informato del nome del maniero dov’era alloggiato e avendo notato che il suo letto era collocato contro una porta murata, che una volta dava l’accesso alla torre sovrastante, fece sgrottare l’esile muro e s’avvide allora con disappunto che celava una porta di ferro. S’avverava dunque la malevola profezia.
Avvolto nell’alone di una profetica leggenda, arrivò anche per Federico il lungo giorno senza tramonto. Chiamò il notaio a cui dettò le sue ultime volontà e l’amico padre Berardo di Castacca, che lo confessò dopo avergli fatto indossare un dimesso saio monacale (anche se pare che in extremis - in un estremo sussulto di impenitente laicità - abbia sussurrato: post mortem nihil.)
Moriva così, nell’amata Puglia, dove la sua presenza lasciava testimonianze durevoli e significative del suo passaggio, fra le quali la trasformazione del dialetto apulo-siculo in volgare illustre, una profonda riforma legislativa, e soprattutto la costruzione di numerosi castelli che resteranno per sempre ad attestare la sua imperitura memoria, sovrano medievale, e tuttavia ancora oggi, a distanza di oltre 800 anni, una delle presenze più singolarmente moderne che ancora fa riecheggiare fino a noi l’eco lontana della sua inconfondibile voce.
Secondo Matteo Paris quella notte si udì un fragoroso tuono nel momento stesso della morte del sovrano e il cielo fu solcato da una cometa che attraversò le terre dell’Impero da Oriente a Occidente. Cecidit sol mundi, comunicò il figlio Manfredi ai sovrani dell’Impero, s’era spenta la luce del mondo.
Renato Russo
(15 novembre 2017)
 |
 |
Barletta, l’ala federiciana del Castello. Al centro l’arco che immette a sinistra nelle grandi sale sveve (inferiore e superiore) oggi adibite a Biblioteca comunale, e a destra alla grande torre normanna (Fotorudy) |
Michele Scoto consegna al sovrano la traduzione dei libri di Aristotele. Scienziato arguto dalla cultura enciclopedica, era anche astrologo, filosofo, traduttore dall’arabo e indovino. Vaticinò, fra l’altro, che l’imperatore sarebbe morto sub flore (Tela di G. Conti) |
 |
 |
Castello di Gioia del Colle, costruito su preesistenze normanne, trasformato in soggiorno residenziale intorno al 1230 |
Castel del Monte, il più rappresentativo ed emblematico dei castelli federiciani |
 |
 |
Castello di Apricena, la domus solaciorum fatta costruire da Federico II nel 1225. Non è però quella che vediamo oggi |
Lucera, il palazzo di Federico (Desprez) |
 |
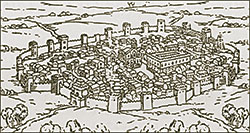 |
Il convivio imperiale |
Foggia, antica pianta della città. La reggia è il grande palazzo accanto alla Cattedrale (ricostruzione in un disegno di A. Cimaglia) |
 |
|
Ruderi di Castel Fiorentino (V. Baltard) |
|
<< vai all'indice del canale |